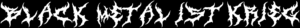Manfred Eduardo Schmidt non è di certo una persona che sa stare con le mani in mano. Infatti il mastermind di Wintarnaht e Dauþuz, dopo le due canoniche settimane di ferie tra un disco e l’altro (da pochissimo recensito su queste pagine il buon lavoro dei Dauþuz “Monvmentvm”) ha deciso di far uscire il debut album della sua altra band, Isgalder, la più recente per data di formazione ma di sicuro non la meno esperta. Nato dalla sua mente sempre attiva nel 2017, dopo un ep e uno split, il progetto esce con questo disco dalla bella copertina, biglietto da visita che ci può far intuire la direzione lirica e musicale dei nostri. “Canto glaciale”, questo significa in italiano Isgalder: i nostri ci propongono un black metal a forti tinte pagane e ambientali, senza mai tralasciare venature epiche, che rendono la fruizione più complessa. Considerato l’ultimo ottimo lavoro marchiato Dauþuz, erano alte le aspettative nei confronti di questo primo disco degli Isgalder, aspettative che purtroppo non verranno del tutto rispettate perché l’ascolto risulterà spesso e volentieri confusionario, soprattutto considerato quello che oggi giorno, in un modo o nell’altro, dovrebbe essere un valore aggiunto: la produzione e il mastering del disco. In “The Red Wanderer” ci sono tutti i classici stilemi del pagan black metal: chitarre zanzarose, harsh vocals che si alternano con clean più evocative, rumori di natura e strumenti folkloristici, ma qualcosa, dopo svariati ascolti, non va. Come ogni buon disco pagan ambient black metal che si rispetti, seguendo il più classico dei clichè, l’apertura spetta a un’intro che, da suoni prettamente eterei, si evolve chiamando in causa chitarre, batteria e cori evocativi, che brevemente lasciano spazio a synth che aprono alla prima vera e propria song del platter “Funeral Fire”: buon brano di atmospheric black metal, mai scontato nel suo alternare sfuriate old school, tra tremolo, blast e scream altissimi, a momenti più ragionati con voci pulite e synth in primo piano, usati come collante dei vari cambi d’atmosfera.

L’apice è appena dietro l’angolo e “Soaring Mountains” ci stupisce per la sua bellezza che richiama le prime registrazioni dei Falkenbach o addirittura i vecchi Ásmegin, grazie alle controvoci più alte ed epiche; il tutto abbellito da un bel solo di matrice heavy, in un costante crescendo di atmosfere eteree e sognanti per i sei minuti di durata della song. La titletrack non è da meno e non fa altro che incrementare il nostro entusiasmo, facendoci pensare d’essere al cospetto di un disco di grande qualità. Ma purtroppo l’illusione svanisce lentamente, appena iniziamo a captare i limiti e i difetti di quest’opera. Le prime tre tracce, per ispirazione e sensazioni, si muovono su binari sufficientemente standard per il genere ma, grazie alla loro genuinità e ad un suono grezzo e minimale, entusiasmano non poco. Ma da questo punto in poi ci troviamo dinnanzi a uno strascico di idee e soluzioni che pare davvero un copia incolla di questi primi minuti assaporati con piacere. “Sirius Ablaze” di sicuro non fa sobbalzare l’ascoltatore, tranne che per alcuni cambi di tempo che sembrano fatti in maniera improvvisata al limite dell’approssimativo. Lo stesso dicasi per le due successive tracce: si segnalano le buone linee vocali pulite di “Ulterior Worlds” e il break atmosferico con tanto di guitar solo in “Empire Of Ice”, ma si tratta di pezzi che appesantiscono l’ascolto per l’eccessiva similitudine con le prime tracce del lavoro e per la medesima struttura ritmica e la somiglianza delle linee vocali. Un’ulteriore punto interrogativo, grande quanto una casa, ci viene posto dalle ultime due tracce, interamente strumentali e atmosferiche, prevalentemente composte da suoni di natura, chitarra acustica e vaneggi vocali: se avessero avuto una durata contenuta, usate come intermezzi, avrebbero avuto la loro funzione nell’economia del disco, ma sono poste in conclusione e sommate tra loro raggiungono quasi la mezz’ora, in pratica metà della durata dell’intero lavoro.

A completare l’opera ci pensa una produzione che ricorda una sorta di registrazione in presa diretta in una capanna in mezzo alla foresta, molto fedele al lato meralmente nostalgico e ortodosso del black metal: da un punto di vista più tecnico e prettamente qualitativo invece può essere definita semplicemente mediocre. Scelta ragionata e volontaria? Possibile, ma di sicuro opinabile da parte di noi addetti ai lavori. Qui non si tratta di utilizzare i suoni grezzi del black metal primordiale perché il genere proposto dagli Isgalder meriterebbe più accuratezza. Ci troviamo invece di fronte a un disco che suona fiacco e poco potente, a partire dal suono della batteria, più simile a quello delle pentole della cara nonnina consumate dall’utilizzo negli anni: roba da rimpiangere (quasi) il pessimo “St. Anger” dei quattro ex cavalieri californiani. Il basso, praticamente inesistente, non è di supporto alla batteria che, al netto degli orribili suoni, è ben suonata da Moppel, anche se alcuni arrangiamenti risultano banali e di poca fantasia. Le chitarre in molti frangenti sono piatte e soventemente coperte dallo scream. Gli Isgalder quindi esordiscono con un disco che dalle prime battute si preannunciava di tutt’altra fattura, anche per via del buon ep che l’aveva preceduto, dei nomi coinvolti nel progetto e del sostegno di un’ottima etichetta come la Naturmacht Productions, sempre meticolosa al limite del maniacale per quanto riguarda il layout dei prodotti offerti e la qualità in generale. Le buon idee ci sono, i buoni pezzi pure ma, duole dirlo, in troppi momenti regna il chaos compositivo classico del “chi troppo vuole…”, affossato ulteriormente da una produzione non all’altezza e una disposizione dei brani che lascia perplessi soprattutto nella parte finale del disco. Le doti a questi ragazzi non mancano e fanno ben sperare per il futuro, a patto che riescano a raddrizzare il tiro aggiungendo un pizzico di originalità e personalità e lavorando maggiormente sull’impatto e sull’immediatezza dei pezzi perché qui è facilissimo perdersi tra un brano e l’altro, troppo simili tra loro: il rischio è che il disco finisca nel dimenticatoio dopo pochissimi ascolti.