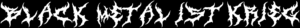Quest’estate l’audience metallica è stata letteralmente monopolizzata dall’evento modaiolo del periodo, ossia l’uscita, dopo oltre dieci anni di silenzio, del disco di una nota band che propone un genere musicale ibrido e in effetti lontano anni luce dal metal, ma che sembra piacere tanto agli odierni metallari hipster con la puzza sotto al naso. Le riviste di settore gridano addirittura al capolavoro e si provvede all’incensamento di questi quattro individui in ogni lato del globo perché fa figo, perché è l’evento del momento; e ciò ha fatto sì che il disco, venduto a prezzi improponibili e fuori mercato nonostante l’edizione speciale, sia andato praticamente sold out. È possibile che la musica sia ridotta a queste mere trovate di marketing e ci si impegni tutti quanti a lodare o affossare un gruppo a seconda di come tira il vento? Per fortuna c’è la più viscerale scena underground black metal, una delle poche dalle quali emergono ancora note scritte con lacrime, sudore e sangue, dove il tornaconto commerciale ha poco a che fare con le strategie di bands che, nella maggior parte dei casi, usano i propri risparmi o si indebitano pur di supportare la propria passione giorno dopo giorno e trasmettere la propria musica ai fans sperduti in ogni parte del globo. Bands per le quali raggiungere l’obiettivo del primo album può voler dire spesso “raggiungere l’America”. I bielorussi Downcross mi hanno stimolato questa prefazione, se volete un po’ sentimentale, in quanto solo poco più di sei mesi fa esordivano sul mercato con il loro riuscitissimo debut album “Mysteries Of Left Path”, ed oggi, a sorpresa, tornano alla carica con un lavoro nuovo di zecca. C’è bisogno di far aspettare anni e anni per scrivere un disco al fine di creare hype e far parlare di sé? No di certo, se hai ispirazione e buone idee da tramutare in musica, e i nostri due amici di Minsk ne sanno qualcosa.

Dzmtr e Ldzmr con ”What Light Covers Not” proseguono il loro occulto cammino e lo fanno nel migliore dei modi, registrando sette nuove tracce di puro black metal indiavolato dai connotati epici e malinconici. Pensare che questo disco possa essere una raccolta di brani scartati dal primo full length sarebbe un grosso errore: dalle prime note dell’opener “To Cross The Path Of Fire” ci si rende conto infatti della qualità di ogni singola nota che compone questi quaranta minuti scarsi di musica figlia del demonio, riprendendo quanto di buono fatto nel predecessore ma aumentando la dose di epicità e melodia. La ricetta è la solita e vincente: sfuriate di blast accompagnate dal più canonico tremolo, che pare provengano dalle lande finlandesi, tanta è la drammaticità di ogni singolo pezzo e la freddezza esecutiva che non lascia spazio a orpelli o divagazioni adolescenziali; dosi massicce di gelida ed epica melodia; screams laceranti che lasciano ampio spazio a harsh vocals più tendenti al growl; qualche inframezzo acustico utile a snellire una tracklist prevalentemente orientata sull’impatto distruttivo e la velocità. Pare scontato dire che in questo disco non si inventa nulla di nuovo: ovviamente è black metal classico dalle forti tinte epiche e melodiche, ma tutto suona molto fresco e spontaneo, senza nessuna forzatura o voglia di apparire o di rendere a tutti i costi omaggio agli Dei del passato. I Downcross sembrano crederci davvero e lo si evince dalla potenza guerrafondaia che sprigionano brani come “Opening The Shells Of Spreading Chaos”, “The Making Will Not Be Commited” o la stessa title track, mazzate senza compromessi, dotate però di ritornelli ben riusciti e melodici, con variazioni sempre tendenti all’epico. Il punto vincente di “What Light Covers Not” è appunto la capacità di suonare classico e “datato” ma al contempo fresco e piacevole: un disco che suona come un qualcosa già sentito, registrato anni e anni fa, ma senza mai risultare ripetitivo o anacronistico, senza mai invogliare a premere anzitempo il tasto skip.

Le tracce acustiche, poste in terza e ultima posizione, sono ottime per incrementare lo spessore atmosferico e dimostrano come questa band abbia studiato ogni mossa in maniera adeguata senza lasciare nulla al caso, così come la produzione, ruvida e old school, ma non per questo priva di qualità (anzi, i suoni risultano ruggenti, equilibrati e mixati alla perfezione; nulla copre nulla e le chitarre graffiano come devono). A fine ascolto ci si chiede effettivamente se per avere un disco di qualità sia necessario aspettare oltre dieci anni, vestirsi alla moda e spendere quattrini su quattrini. La risposta è scritta in queste righe.