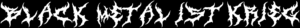“Fragile e delicato, si mostra eretto e peloso, i fiori sono molto particolari e la sua colorazione più tradizionale è rosso porpora, generalmente con una piccola macchia nera interna. Se si considera la cultura romana, il fiore rosso resta centro misterioso dell’oscuro oblio sognante. Ovidio, ad esempio, descrive la notte come una corona di papaveri. Nel linguaggio dei fiori il papavero è simbolo dell’orgoglio sopito, della consolazione, ma anche della semplicità. Da questo derivano alcune simbologie minori e poco diffuse come, ad esempio, lentezza, dubbiosità, sorpresa, sonno eterno, oblio e immaginazione”. Nonostante la copertina eterea e rilassante, raffigurante un soleggiato campo di papaveri in piena primavera, possa suggerire che si tratti di un disco di musica elettronica, ambient e comunque lontanissimo da rock o metal, non abbiamo preso abbagli, in quanto il terzo full length degli olandesi Fluisteraars risulta una delle sorprese dell’anno in ambito atmospheric black metal. Il combo originario di Bennekom, attivo ormai da un decennio, si è scavato una nicchia di tutto rispetto nell’universo underground olandese; in silenzio, anzi sussurrando (Fluisteraars significa infatti “coloro che sussurrano”), si è fatto strada riuscendo a salire agli onori della cronaca nelle ‘zine di settore, grazie ad una proposta che si basa su un classico black metal, arricchito però da elementi progressivi, avantgarde, atmosferici, al limite del post-rock/shoegaze bagnato da un certo flavour dark. Anche grazie all’utilizzo di strumenti atipici per il genere, come tamburi, timpani, trombe, archi, i nostri sono riusciti a distanziare il loro sound da quei canoni abusati che spesso fanno ricadere anche tante buone band in una dimensione standard e nel conseguente oblio.

Niente di assolutamente nuovo ma effettivamente il panorama black atmosferico è ancora una fucina di potenziale espressivo per i gruppi che riescano ad evitare i più classici “errori” del genere, come l’eccessiva nebulosità del riffing o il loop di riff estremamente simili tra loro, ripetuti fino alla nausea, che rende difficile distinguere un brano dall’altro: i Fluisteraars riescono invece nell’ardua impresa di colpire e coinvolgere l’ascoltatore già dai primi istanti e in questo sta la forza di questo disco, di agevole fruizione, quasi immediato nell’assimilazione e comprensione dei riff e delle linee compositive dei pezzi. Composto da cinque brani, per una durata totale di poco più di mezz’ora, “Bloem”, che in olandese significa “fiore”, può essere astrattamente diviso in due parti: la prima, più classicamente black, è composta dai primi due brani; il terzo, grazie al suo mood alternativo, funge da spartiacque ed introduce la seconda parte, più sperimentale, progressiva e intimista, dove la band esplora mondi paralleli ed eterei. In “Tere Muur” e “Nasleep” emerge come detto l’anima più canonicamente black della band, grazie a bordate disumane, affilate e feroci, con tremolo, blast beat e scream a dirigere l’orchestra infernale senza interruzione. Si arriva così a “Eeuwige Ram”, vero e proprio apice del disco, grazie al suo mood sognante e rilassato, con chitarre più pulite e piene e vocals che, pur non lesinando rabbia, danno più spazio alla melodia: la band riesce a creare un sound che spazia dai Bathory più epici (periodo “Blood On Ice”, per intenderci) a influenze gotiche simil Paradise Lost dell’era alternativa. Un vero pezzo da novanta che dà il via alla seconda parte del lavoro, quella che mette in evidenza un’altra delle caratteristiche che rendono “Bloem” un disco vincente, ossia la sua carica emozionale. “Vlek” è definitivamente la migliore traccia del disco, per la capacità della band di racchiudere in sette minuti tutto il meglio della musica estrema: si parte con un’esplosione di rabbia che rievoca fiordi norvegesi, dolore e malinconia, grazie al poderoso lavoro di chitarra che, messa da parte la velocità a metà song, abbandona l’oscurità per lasciare spazio a sprazzi di luce celestiale; i suoni si fanno suadenti, rievocando campi di grano in pieno giugno; dalla bestialità dei Darkthrone si passa all’apparente solarità dei The Cure di fine anni novanta, con tutto il campionario di strumenti che la band ha a disposizione e che rende questa song di un livello superiore e di gran lunga la migliore scritta dai nostri dagli esordi a oggi.

Le emozioni non finiscono qui e ci pensa la conclusiva “Maanruïne” a chiudere i conti: altro grande brano, dove la band concilia suoni ancestrali dai tempi soffusi, al limite dello shoegaze, con la ferocia efferata del black della second wave, pesando minuziosamente il tutto con un inizio esasperato, per poi proseguire sino alla chiusura del disco in un percorso di maestria atmosferica, grazie a strumenti a fiato e chitarre che intrecciano una tela di pregiata fattura. Se “Bloem” inizia quindi in maniera dirompente e devastante, si giunge alla conclusione con morbide chitarre che ci cullano in un tiepido pomeriggio primaverile, lasciandoci del tutto scossi e increduli. E se alla band possiamo rimproverare un utilizzo troppo monocorde del cantato (la presenza di clean vocals avrebbe di sicuro avvalorato ulteriormente i pezzi) e una durata forse troppo ridotta dell’intero lavoro; non possiamo esimerci dall’applaudire la genialità delle soluzioni, sempre caratterizzate da semplicità e immediatezza melodica, e la capacità del gruppo di fondere pregevolmente luce e buio, mescolando generi diversi tra loro e fornendo all’ascoltatore una colonna sonora al contempo radiosa e dolorosa. “Bloem” dimostra come si possa suonare un genere ostico e a tratti alienante come l’atmospheric black metal in maniera semplice, senza mai cadere nello scontato ed anzi utilizzando la semplicità come punto di forza: al momento è una delle uscite dell’anno nel genere; per la band in futuro sarà davvero difficile ripetersi ma sarà un piacere per noi attendere la prossima release ascoltando senza sosta questo grandissimo disco.