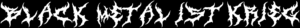Terzo album in circa trentacinque anni di attività, non si può certo dire che i Tsatthoggua siano una band iperattiva. Ma ve li ricordate i Tsatthoggua? Questi tedesconi, che univano (e uniscono) un moniker di derivazione lovecraftiana con un’insana passione per il caprone, il latex, il bondage e le perversioni sessuali varie ed assortite che ne derivano, furono autori nell’ormai lontano 1996, via Osmose Productions, di “Hosanna Bizarre”, debutto che li rivelò come una delle band più caotiche e (appunto) bizzarre allora in circolazione e che ancora oggi è circondato dal proverbiale, e probabilmente per una volta meritato, alone di culto. Dopo il seguente, ma meno ispirato, “Trans Cunt Whip” del 1998, dei Tsatthoggua si erano completamente perse le tracce. Fino a questo ritorno, che li vede sempre fedelmente coniugati con la nota etichetta francese e si presenta con una copertina davvero fichissima, che ovviamente ribadisce le ossessioni concettuali dei nostri amici. E quindi come suona questo “We Are God”? La prima cosa che balza immediatamente all’orecchio è la registrazione potente e levigata, lontana anni luce dalla sporca approssimazione del debutto. La seconda è una sterzata stilistica piuttosto decisa, che avvicina decisamente il quartetto teutonico al black/death metal nella sua forma più moderna.

Tuttavia una produzione e un sound più al passo con i tempi non implicano affatto che i Tsatthoggua si siano rammolliti, tutt’altro. Certo, questo disco rispetto al passato suona meno folle e imprevedibile, se vogliamo per molti aspetti più rigido e granitico, ma ciò che il gruppo ha perso in “stranezza” (ad esempio sono del tutto sparite le funamboliche intrusioni tastieristiche che caratterizzavano “Hosanna Bizarre”, sostituite da brevi intro rumoristiche) lo ha guadagnato in sanguinosa furia e ferocia espressiva. Per non parlare dell’incredibile progresso compositivo che emerge dal paragone con l’acerbo, per quanto indubbiamente affascinante, debutto. I Tsatthoggua sono maturati e sono passati dal lasciarsi andare a scoppi di rumore belluino allo scrivere canzoni “vere” e varie, che risultano perfino catchy e memorizzabili dopo una manciata di ascolti, pur senza mai strizzare l’occhio a soluzioni morbide o troppo facilmente “accessibili”. Qui è tutto un tripudio di blast beats e chitarroni, con sprazzi di sinistra melodia che si fanno strada in qualche ritornello qua e là, e i pezzi tirati, anzi tiratissimi, fino allo spasimo, rappresentano la quasi totalità della tracklist. Tra questi citerei soprattutto la doppietta iniziale formata dall’opener “Master Morality” e dalla seguente “Vorwärts Vernichter”, o la più black oriented “No Paradise For Human Sheep”, o ancora la conclusiva “Pechmarie”, canzoni da manuale della violenza (“controllata”) in musica, che dimostrano una volta di più come si possa suonare assolutamente estremi senza scadere per forza di cose nella cacofonia fine a sé stessa.

Si potrebbe dire che è come ascoltare gente tipo Sadistik Exekution o primi Impaled Nazarene ma inquadrati in strutture più ordinate ed “educate”, con il risultato che il nichilismo sonoro emerge in maniera ancora più fredda e chirurgica. Altrettanto letali e forse ancora più riusciti sono i brani dove la band alza leggermente il piede dall’acceleratore e si concentra su mid tempos sinuosi e blasfemi, come “The Doom-Scrawl Of Taran-Ish” o la successiva “I Drive My Dogs (To Thule)” e soprattutto la title track, che a mio giudizio costituisce l’episodio migliore, e sicuramente il più anthemico, di un album dove la qualità media è veramente molto alta. In definitiva valeva la pena aspettare e forse è preferibile centellinare le uscite piuttosto che produrre un disco all’anno (tutti uguali, tutti insignificanti) come fanno in molti (troppi). Un lavoro ottimamente composto e ottimamente suonato, che si candida prepotentemente ad essere una delle uscite underground dell’anno.