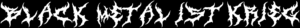Non è semplice descrivere a parole la musica proposta dai norvegesi Forgotten Woods in questo loro secondo full length, sospesa com’è in equilibrio precario tra un black metal ruvido ed essenziale dall’andamento ossessivo (direi anzi che il depressive nasce proprio con loro e i coevi lavori di Burzum) e soluzioni ardite, davvero inaspettate se si pensa al periodo in cui fu pubblicato (anche se il black metal, perfino negli anni del trionfo dell’ortodossia, è sempre stato un calderone di sperimentazioni varie). I primi due pezzi, costruiti su un riffing secco e quadrato, sono quelli più classici e riportano immediatamente alle sonorità del debutto “As The Wolves Gather” (altra perla oscura della band capitanata da Olav Berland e Rune Vedaa): “Overmotets Pris” e “My Scars Hold Your Dreams” sono due cavalcate nella notte, emotivamente coinvolgenti e impreziosite da cambi di tempo ed azzeccatissimi stacchi acustici. Con “The Starlit Waters / I, The Mountain” e i suoi misteriosi cori in clean vocals, la musica cambia e diventa multiforme e sghemba, carica di influenze disparate e difficilmente catalogabili, pur restando (non fosse altro che per l’interpretazione vocale marcia e disperata del singer Thomas Torkelsen), fondamentalmente e nonostante tutto, ancorata ad una tradizione che proprio allora andava definendo i propri canoni espressivi. L’intermezzo strumentale dal gusto blues rock “With Swans I’ll Share My Thirst” (dichiarato omaggio ai Velvet Underground) introduce in modo inconsueto agli ultimi due brani, quelli più schizofrenici e sfuggenti. “Den Ansiktløse” e “The Velvet Room” sono nebbiose e acide divagazioni che uniscono melodie ed atmosfere ancora saldamente black a tentazioni post-punk e post-rock, arrivando a ricordare (almeno a livello di sensazioni suscitate) perfino i Bauhaus o i Joy Division o, per non andare troppo in là, i Joyless, progetto parallelo degli stessi Forgotten Woods che esordisce nello stesso anno di “The Curse Of Mankind” e che di lì a poco si staccherà definitivamente dal metal per seguire la strada del rock depressivo tout court. Elucubrazioni stilistiche e paragoni azzardati (così cari a noi poveri scribacchini) a parte, resta la sostanza di un disco incredibilmente d’avanguardia (ma assolutamente non avantgarde, almeno nel senso comune dato al termine in ambito black) che cambia forma e muta un genere pur restando all’interno dello stesso: il che è davvero prerogativa soltanto dei più grandi.
Sign in
Welcome! Log into your account
Forgot your password? Get help
Password recovery
Recover your password
A password will be e-mailed to you.