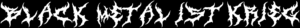Gli Invocation Spells sono cileni, di Santiago, e come da tradizione sudamericana, quando si suona black metal, lo si fa in modo ortodosso e becero. Giunto al quarto full lenght in soli quattro anni il combo non cambia la formula proposta; una sorta di thrash/black’n’roll che, detto così, pare una presa per il culo, ma è effettivamente quello che suonano questi ragazzi. Le fortissime influenze ottantiane contaminano minuto dopo minuto ogni singola traccia partorita dalle menti malate di Obssessor e Witchfucker, cresciuti con i poster di Cronos sopra il letto e dentro l’armadio, anziché quelli di una coniglietta qualsiasi di Playboy, indossando pantaloni in pelle e cartucciere già in tenera età, anziché il più classico dei grembiulini scolastici. Questa nuova fatica non cambia in pratica di una virgola la strada intrapresa nei dischi precedenti ma la segna ulteriormente con paletti ben definiti: da qui non si scappa, le novità stanno a zero, le tracce sono tutte uguali, tant’è che viene difficile poter identificare tra queste otto le migliori e le peggiori. L’apertura affidata a “Ruins Of Cemetery” lascia ben presagire, con un main riff che pare quasi uscito da “Kill ‘Em All” (con le dovute precauzioni), per poi farci tornare su territori mötorheadiani iniettati di anfetamine malsane. Le linee vocali peccano di personalità, nel senso che se scambi quelle della seconda traccia e le metti sulla settima ci calzano a pennello come una maglietta slimfit elasticizzata. Tra tutto questo marciume incontrollato degna di menzione è di sicuro “Spread Cruelty”, ennesimo episodio sparato a mille (anche se gli Invocation Spells non prediligono i blast si addentrano in tempi sempre e comunque sostenuti), ma qui figura pure il cantato pulito che, onestamente, non so se sia un bene o un male vista l’effettiva utilità marginale nell’economia della song e del disco.

Otto canzoni di veleno e rabbia elementare, un feto di metallo nero; così può essere definito “Spread Cruelty In The Abyss”, un concentrato di pesticida della durata di venticinque minuti che passano bruciando l’erba che viene calpestata dal cavallo nero rampante in copertina. Una menzione merita sicuro la produzione, che pur non avendo a che fare con un “Chinese Democracy”, si lascia ascoltare con piacere senza fare fatica nel distinguere qual’è la chitarra, la batteria o il citofono di casa che suona per via dell’ennesimo portalettere passato questa mattina. Dilungarsi su questo disco è inutile, sarebbe buttare parole al vento, pertanto, se vi piace un genere estremo che pare uscito da una gattabuia e prende a piene mani dagli insegnamenti di Venom, Mötorhead, con spruzzi black e harsh vocals provenienti da oltretomba bene, sennò statevene più lontani possibile.